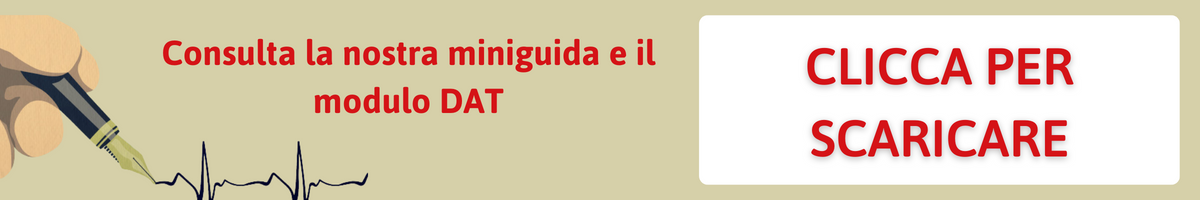Cosa si intende per accanimento terapeutico? Secondo quali criteri il medico può scegliere di sospendere le cure? Sospendere trattamenti inutili significa accorciare la vita e di fatto applicare l’eutanasia? Queste sono solo alcune delle complesse domande a cui il codice deontologico dei medici prima e la legge 219/2017 poi hanno cercato di dare risposte. Non è semplice parlare di un tema così complesso e pieno di sfaccettature, né è nostra ambizione essere esaustivi in merito. Tuttavia, pensiamo sia importante dare accesso a una base informativa, dato che nell’interpretazione delle norme sull’accanimento terapeutico resta ancora un margine di discrezionalità. Per affermare le proprie scelte su quali cure accettare e quali rifiutare è possibile esprimere il proprio consenso informato, in cui si incontrano l’autonomia decisionale del paziente da un lato, l’autonomia professionale e la responsabilità del medico dall’altro. È anche possibile esprimere le proprie volontà ora per allora attraverso le DAT (Disposizioni Anticipate di Trattamento).
Accanimento terapeutico: definizione e confini interpretativi
Per accanimento terapeutico si intende un irragionevole eccesso nelle cure, attraverso terapie che non portano alcun giovamento al paziente. Ma come si fa a determinare in maniera oggettiva quando le terapie sono eccessive e quindi procedere alla loro sospensione? L’articolo 2 della legge 219 ha tentato di rispondere a questo quesito, applicando dei confini precisi alla definizione di accanimento terapeutico:
“Nei casi di paziente con prognosi infausta a breve termine o di imminenza di morte, il medico deve astenersi da ogni ostinazione irragionevole nella somministrazione delle cure e dal ricorso a trattamenti inutili o sproporzionati. In presenza di sofferenze refrattarie ai trattamenti sanitari, il medico può ricorrere alla sedazione palliativa profonda continua in associazione con la terapia del dolore, con il consenso del paziente.”
Da questa affermazione si evince che il medico è tenuto a interrompere le cure, e quindi evitare l’accanimento terapeutico, quando il paziente è in una condizione di prognosi infausta a breve termine o di imminenza della morte.
Invece nell’articolo 16 del codice deontologico si fa esplicito riferimento al miglioramento della qualità della vita come discriminante per determinare se una terapia è o meno accanimento terapeutico:
“Il medico, tenendo conto delle volontà espresse dal paziente o dal suo rappresentante legale e dei principi di efficacia e di appropriatezza delle cure, non intraprende né insiste in procedure diagnostiche e interventi terapeutici clinicamente inappropriati ed eticamente non proporzionati, dai quali non ci si possa fondatamente attendere un effettivo beneficio per la salute e/o un miglioramento della qualità della vita”.
Infine, è interessante ricordare anche la posizione della Chiesa Cattolica rispetto alla differenza tra eutanasia e sospensione di trattamenti inutili: nella lettera enciclica Evangelium vitae di papa Giovanni Paolo II del 1995 sul valore e l’inviolabilità della vita umana si afferma che:
“Quando la morte si preannuncia imminente e inevitabile, si può in coscienza rinunciare a trattamenti che procurerebbero soltanto un prolungamento precario e penoso della vita, senza tuttavia interrompere le cure normali dovute all’ammalato in simili casi.”
In sostanza interrompere le cure in caso di morte imminente e inevitabile significa lasciare che la malattia faccia il suo corso naturale, mentre con l’eutanasia e il suicidio assistito si procura volontariamente e anticipatamente l’interruzione della vita. Allo stesso modo quindi il rifiuto di un trattamento da parte del paziente non può essere confuso con il suicidio assistito, che consiste nell’assunzione volontaria da parte del paziente di sostanze con l’intenzione di interrompere immediatamente la sua esistenza.
Il consenso informato, una scelta consapevole e volontaria
Al di là delle definizioni possibili di accanimento terapeutico, al medico spetta il compito di definire quali siano le terapie appropriate – e quindi in un certo senso idonee – ma sta al paziente decidere se sono proporzionate per lui, quindi se compatibili con la sua idea di qualità della vita. Ecco perché la legge 219 dà centralità al diritto di rifiutare in tutto o in parte i trattamenti proposti dal medico, attraverso il consenso informato, che è un diritto costituzionale. L’articolo 1 afferma infatti che:
“Nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge”.
Questa scelta libera e volontaria deve essere documentata in forma scritta o tramite videoregistrazione e il medico è obbligato ad attenersi, rispettando le volontà del paziente, senza avere nessuna responsabilità civile e penale sulle conseguenze di queste scelte. È possibile infatti esprimere il proprio consenso o meno ai trattamenti pensando a quando non saremo più eventualmente in grado di farlo, estendendo così il nostro diritto all’autodeterminazione attraverso la compilazione delle DAT, comunemente note come “testamento biologico”.
Scelte di fine vita condivise con VIDAS: le storie di Silvia e Giuseppe
Una parte integrante del lavoro degli operatori VIDAS consiste proprio nel raccogliere le volontà dei pazienti in merito a quali trattamenti ricevere o rifiutare, in particolare nel fine vita, a fronte dell’evoluzione naturale della loro patologia. Ciascuno di loro si è opposto all’accanimento terapeutico per motivazioni differenti, determinate dai valori e dai principi in cui credevano fermamente.
Vi invitiamo ad approfondire queste due storie, per comprendere l’eterogeneità e la complessità delle scelte relative al fine vita:
- la storia di Silvia, spinta dal desiderio di non perdere mai la propria dignità;
- la storia di Giuseppe, uomo d’altri tempi che non voleva rimanere attaccato ad una macchina.