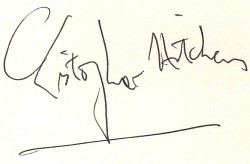 Di solito quando mi trovo a parlare o scrivere di un libro, rifuggo dai risvolti di copertina. Lo trovo banale, non già per le cose scritte, talvolta assai apprezzabili per contenuti e capacità di sintesi, ma per evitare di ripetere concetti che altri hanno meglio elaborato perché farina del loro sacco. Il libro, ogni libro, va letto sino in fondo e se non hai nulla da aggiungere a quanto descritto nelle presentazioni, lascia perdere.
Di solito quando mi trovo a parlare o scrivere di un libro, rifuggo dai risvolti di copertina. Lo trovo banale, non già per le cose scritte, talvolta assai apprezzabili per contenuti e capacità di sintesi, ma per evitare di ripetere concetti che altri hanno meglio elaborato perché farina del loro sacco. Il libro, ogni libro, va letto sino in fondo e se non hai nulla da aggiungere a quanto descritto nelle presentazioni, lascia perdere.
Faccio un’eccezione per la straordinaria testimonianza che ci ha offerto Christopher Hitchens con “Mortalità” e riporto un paio di righe che mi hanno colpito:
È la storia esemplare del rifiuto di accucciarsi di fronte all’ignoto e una lucida indagine sulla condizione umana… il testamento di Hitchens non è solo una brillante e coraggiosa opera di letteratura, ma anche la rivendicazione della dignità e del valore dell’uomo.
Ecco, proprio dignità e unicità delle persona sono i concetti nei quali, consapevolmente o no, mi sono imbattuto lavorando con Vidas da volontario. L’insieme delle cure offerte a chi sta percorrendo la via della terminalità ha come scopo essenziale la salvaguardia degli irripetibili valori che reca in dote l’essere umano.
Perciò ogni tratto di vita, per quanto breve possa essere, è talmente prezioso da parere un’eternità. Se così non fosse, la moglie di Hitchens, Carol Blue, non avrebbe scritto nelle note conclusive: “La fine è stata inaspettata” anche se stavano trascorrendo le ultime ore di una sentenza scritta da mesi. Quando leggo i suoi appunti, aggiunge Carol, “sento la sua voce ed è lui ad avere l’ultima parola”.
Christopher Hitchens è stato intellettuale, scrittore, saggista americano noto in tutto il mondo. Due anni fa, in una stanza d’albergo di New York, avverte i primi sintomi del male al quale si arrenderà nel dicembre 2011: “Nella vita mi sono svegliato più volte sentendomi la morte addosso: ma niente mi aveva preparato a quel primo mattino di giugno in cui ripresi conoscenza con la sensazione di essere incatenato al mio stesso cadavere”.
Così Hitchens inizia il racconto dell’ultimo viaggio in compagnia di se stesso, delle proprie ansie, delle paure, delle speranze fugaci, una migrazione dal paese dei sani oltre il desolato confine della terra della malattia. Un cammino che le teorie vorrebbero a tappe, dalla negazione alla rabbia sino all’accettazione ma che nell’esperienza di Hitchens assume altre sembianze. Dalla tormentosa sensazione di spreco (perché io con tutti i progetti pensati per il prossimo decennio?) alla fase della contrattazione (sì alla chemio in cambio di qualche anno utile in più) sino alla sensazione che quel dolore non se ne andrà mai (l’attesa della prossima iniezione è ingiustamente lunga).
Tuttavia la consapevolezza dei propri limiti e della propria finitezza mai impedisce a Hitchens di farsi cronista della propria disavventura, spesso con disincanto e ironia. È l’abitante di “tumortown” costantemente assillato da voci di possibili cure che si rivelano esposizioni di cose risapute; è il malato assillato da domande quotidiane “Come stai? “ alle quali risponde: “A quanto pare oggi ho il cancro”; è il paziente che non fa più novità con il suo tumore maligno anche quando la voce si riduce “a uno squittio acuto come quello d’un bimbo”. È, ancora, l’intellettuale che si chiede perché mai gli sia sembrato un pensiero profondo la frase di Nietzsche: “ciò che non mi uccide mi rende più forte”, contraddetta dalla sua diretta esperienza.
Il sentiero di Hitchens sta per giungere alla fine. Ora il suo scritto è composto da annotazioni frammentarie rimaste incompiute. Un caleidoscopio di pensieri che si conclude riflettendo sulla vita che porta con sé una lista infinita di parenti che di fatto non muoiono mai, pronti a dare consigli:
I figli- scrive citando il romanzo I sogni di Einstein di Alan Lightman- non sfuggono mai all’ombra dei padri: né le figlie a quella delle madri. Nessuno diventa mai indipendente. Tale è il costo dell’immortalità. Nessuna persona è intero. Nessuno è libero.




